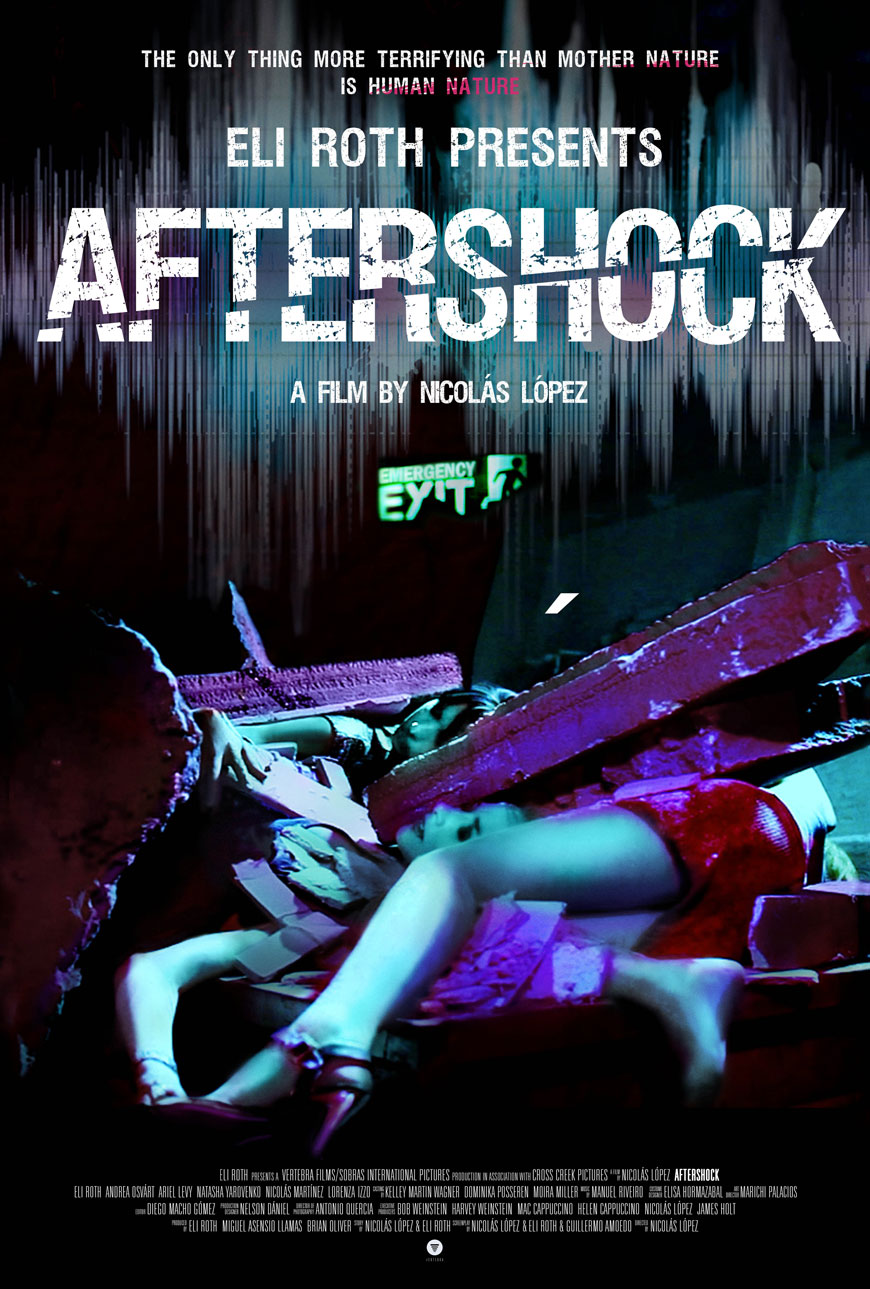Chi sta perseguitando la famiglia Barrett? Chi è "l'uomo dei sogni" che invade le notti del loro figlio più piccolo, Sammy? Con gradualità inesorabile la vita dei Barrett si trasformerà in un vero incubo, contrassegnato da esperienze sovrannaturali inspiegabili...
"Dark Skies" parte bene, soprattutto lungo tutti i titoli di testa, con quelle immagini di quotidianità della media borghesia americana che vive soleggiati e sereni week-end mentre i bambini sguazzano nelle piscine delle loro linde villette di provincia, con gli amici di famiglia venuti a cena con le figlie adolescenti a fare gossip sugli amanti di varie altre conoscenze comuni, e così via. Sto dicendo che il film fa ben sperare, anche dopo i titoli di testa, almeno fino al ventesimo minuto, dopodiché si sfalda letteralmente a causa di una sceneggiatura che si porterà sulle spalle fino alla fine della pellicola tutte le colpe di un disastro narrativo davvero cospicuo. Man mano che i fenomeni "paranormali" iniziano ad entrare in scena, assistiamo a dialoghi familiari, in particolare tra genitori e figli, ancora abbastanza convincenti. Poi, quando lo script vira nei territori pseudo perturbanti di un alien-horror criptico quanto simultaneamente banale, anche le interazioni tra i personaggi si sfilacciano, e soprattutto la relazione tra marito e moglie (Lacy e Daniel) diventano surreali e comunque assolutamente non credibili. Ma è appunto la sceneggiatura, cioè l'architettura narrativa del film, ricordiamolo bene, il punto debole, la faglia sommersa instabile che genera tutti i terremoti possibili cui assistiamo in superficie: una narrazione lenta, diluita, che qua e là ci mostra piccoli colpi di scena esattamente là dove ce li aspettiamo, cercando di pescare negli inutili stilemi di un deja vu che non è neppure capace di utilizzare (certe atmosfere ricordano ad esempio "The box", di Richard Kelly, 2009, film peraltro piuttosto superfluo nel panorama sci-fi-horror contemporaneo; in altri punti si riprende addirittura l'Hitchcock de "Gli uccelli", 1963, con una presunzione di cui non sia ha la benché minima consapevolezza). Il film si stira e tira in lungo e il largo tentando vanamente espedienti perturbanti di varia natura, nonché evocando sottotesti psico-sociologici come quello della solitudine adolescenziale di Jesse, il figlio più grande. Ma tutto è inutile: ogni tentativo di rianimare l'oggetto inanimato si rivela sterile e privo di qualsiasi verve, sia dal punto di vista del puro intrattenimento, che da quello della suspense. In "Dark Skies" nulla è perturbante, tutto è terribilmente ampolloso, e il finale è una summa di tale futile ampollosità, con quel "colpo di scena" da terzo atto horror che fa solo cadere le braccia, e non solo quelle. La caratterizzazione psicologica e la scelta di casting sono due ulteriori elementi che azzoppano ancora di più il film, se ce ne fosse stato bisogno: Josh Hamilton, il padre, viene ripreso da Stewart attraverso primi piani in cui dominano i suoi occhioni sgranati e amorevoli da buon capofamiglia che guarda l'erba del vicino sempre più verde della sua, e l'effetto generale è quello di una mielosità nauseante, anche quando Hamilton cerca di mettere in scena il dramma di un architetto al limite della disoccupazione più nera in tempo di crisi. Il suo girovagare da uno studio all'altro proponendo i suoi disegni possiede meno spessore drammatico di una puntata dell'Ispettore Derrick, e rimanda ancora una volta ad un tasso di presunzione piuttosto elevato da parte del regista che è anche responsabile della sceneggiatura. Infatti ci si domanda subito come sia possibile pretendere di innestare su uno script del genere anche l'ipotesi di una riflessione sociale sulla crisi economica mondiale che stiamo attraversando. Tale riflessione passa immediatamente in secondo e terzo piano, assorbita dalla melassa alienoide che Stewart spalma su tutta la pellicola, nonché da una caratterizzazione paterna psicodramatizzata da Hamilton in un modo che definire opaco è un eufemismo. Keri Russel, mamma Lacy, si pone sulla stessa linea del marito: è colta da sonnambulismo durante il suo lavoro di agente immobiliare, sbatte la testa contro i vetri di una casa che deve vendere a dei clienti, scorge alieni vaganti nella camera da letto di suo figlio Sammy, vede il marito in stato catatonico nel giardino di casa, scopre lividi a forma di disegni da Star Trek sul corpo dell'altro figlio Jesse, ma alla fine mantiene una freddezza che anche Buddha le invidierebbe, e che ovviamente non può convincerci. Durante questo lavorìo monocorde sul quartetto familiare Stewart forse si accorge di annoiarsi da solo, quindi introduce una sorta di deus ex machina improvvisato, cioè il signor Pollard (K.K. Simmons), lo studioso di alieni, dalla faccia da allevatore di bovini dell'Arkansas, che appunto vorremmo che tornasse nella sua fattoria perché le sue povere mucche hanno fame. D'altra parte sono perfettamente consapevole che da una casa di produzione come la Blumhouse non potevamo aspettarci finezze cinematografiche particolari, anche a guardare alcuni titoli recentemente in post produzione, per non parlare di quelli già prodotti (vedi: "Le Streghe di Salem" di Rob Zombie, "Paranormal Activity", di Oren Peli, forse l'unico titolo ancora guardabile, ma non certo così fondamentale per la storia del cinema perturbante). In sintesi "Dark Skies" insegue la chimera di aggiungere un tassello al genere horror-sci-fi ma non centra affatto il bersaglio. Al contrario deraglia quasi subito sui binari della scontatezza e della noia. Da evitare.
Regia: Scott Charles Stewart Soggetto e Sceneggiatura: Scott Charles Stewart Fotografia: David Boyd Cast: Keri Russell, Josh Hamilton, Annie Thurman, J.K. Simmson, Dakota Goyo, Jake Brennan, Trevor St. Jhon Nazione: USA Produzione: Alliance Films, Blumhouse Productions Durata: 97 min.